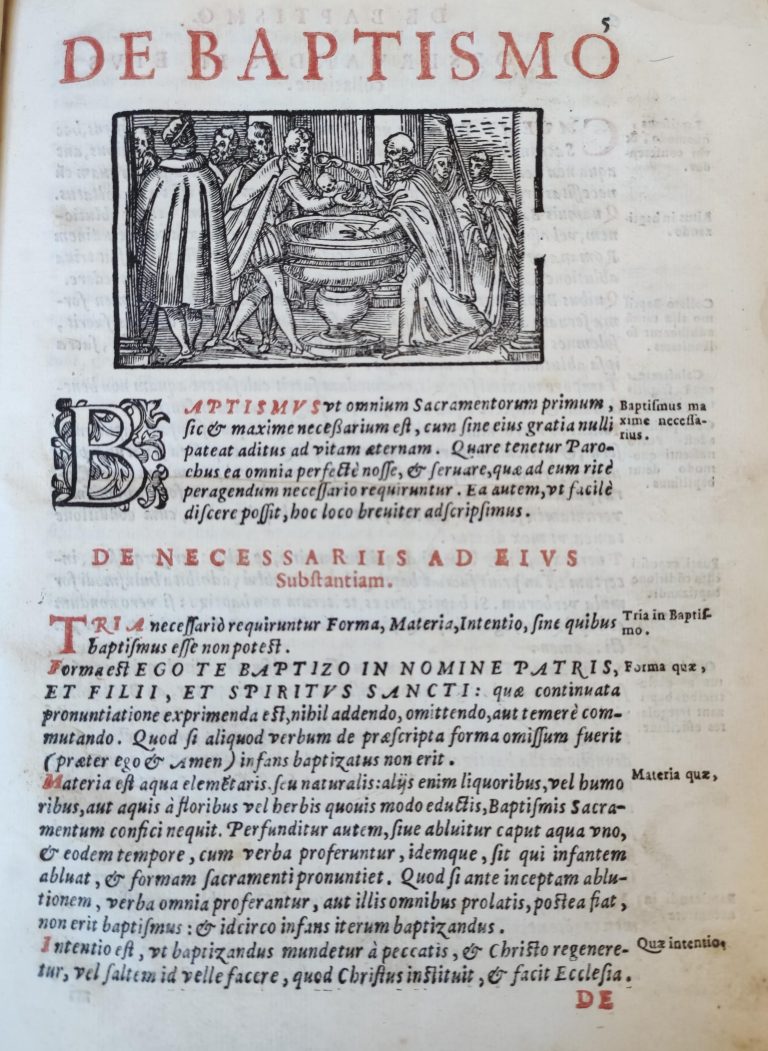Dal Concilio Vaticano II ad oggi
La liturgia persa: dal rituale del 1614 al rito del 1969
La liturgia persa: dal rituale del 1614 al rito del 1969
Per 355 anni il rito latino del battesimo dei bambini è rimasto inalterato, seguendo il “Rituale romanum”, approvato da Paolo V nel 1614, fino all’ “Ordo baptismi parvulorum”, approvato da Paolo VI nel 1969, in seguito alla costituzione sulla liturgia del Concilio Vaticano II. Solo alcune modifiche erano state concesse da Pio XII, nella revisione della liturgia da lui promossa nel 1946, con la possibilità di dialoghi iniziali in lingue nazionali. L’uso della lingua nazionale è diventato abituale in tutti le comunità locali.
Oltre l’elemento più vistoso della liturgia della Parola di Dio, introdotto secondo le linee del Concilio nella celebrazione di ogni sacramento, per il resto l’attuale rito battesimale non ha aggiunto nulla, ma ha semplificato, omettendo alcuni segni e riordinando tra loro alcune parti del rito.
Così la benedizione dell’acqua battesimale, fuori del tempo pasquale durante il quale si battezza con l’acqua benedetta nella veglia pasquale, non è più fatta dal ministro celebrante prima del rito, ma diventa parte del rito quando è necessario benedirla. Sono stati ridotti gli oltre venti segni di croce fatti dal celebrante sul battezzando, su oggetti o durante l’esorcismo e le unzioni.
Tra i segni popolarmente collegati con il battesimo è scomparso il rito del sale, benedetto e posto sulla bocca del battezzando. Il rito dell’“Effatà”, nel rito antico celebrato come parte dell’esorcismo, con il celebrante che toccava la bocca e le orecchie del battezzando con il pollice bagnato della propria saliva, è stato posto come segno esplicativo, senza l’uso della saliva.
Anche la distinzione netta tra la parte penitenziale del rito fino all’ingresso nel battistero del padrino o della madrina con il battezzando, non è più accentuata dal cambio di colore della stola del celebrante dal viola al bianco. La stola stessa veniva utilizzata come segno di accoglienza: il celebrante poneva la parte estrema sinistra della stola sul bimbo per introdurlo in chiesa, dopo i riti iniziali davanti alla porta, quasi a metterlo sotto la sua tutela in questo ingresso, dato che il soggetto non era ancora battezzato.
Uno dei contesti più clamorosi era l’esclusione della madre del battezzando, perché prima di essere riaccolta nella chiesa, doveva sottoporsi ad un rito di purificazione personale, che in molti casi avveniva solo dopo vari giorni dall’avvenuto battesimo.
Se alcuni segni molto familiari di contatto tra celebrante e battezzando sono stati aboliti per la cultura attuale di igiene, la conclamata partecipazione attiva dei fedeli, con l’auspicio delle celebrazioni comunitarie, non è cresciuta molto. Quasi ovunque si è perso il valore di “ingresso” nella Chiesa, con i movimenti processionali, a favore di assemblee di spettatori seduti o al più in movimento per scattare fotografie.
Please , update your browser